L’articolo apparso il mese scorso su The Conversation e scritto da ricercatori che hanno fatto della analisi della letteratura scientifica alla ricerca di forme di frode di diverso tipo il proprio ambito di studio (Joelving, Labbè e Cabanac), riporta, e raccoglie molti degli argomenti affrontati su queste pagine durante lo scorso anno.
Paper mills a review mills, ricerche improbabili che vanno ad alimentare altre ricerche improbabili, con percentuali di inquinamento della letteratura scientifica intorno al 2% (ma che rappresentano solo la punta dell’iceberg). Gift e ghost authorship, ricerche irriproducibili, immagini modificate, dati inventati, tortured phrases, citation networks. Il fenomeno è in crescita, anche se la reazione a questa ondata inquinante è molto lenta, sia per i tempi lunghi che conducono a una retraction, sia per la resistenza opposta dagli editori, sia per un contesto in cui vi è la ferma convinzione che la peer review sia sufficiente e nel fatto che i numeri sono in grado di garantire la qualità (in tempi non sospetti alcuni avevano tentato di fare presente che quella della quantità e dell’accumulo non era la strada corretta, ma hanno prevalso altre strategie, e in alcuni Paesi il raggiungimento di alcuni target è premiato con fondi e posizioni).
Per ciascuna di queste forme di cattiva condotta scientifica l’articolo riporta casi ed evidenze, così come il parere di alcune figure di spicco dell’editoria scientifica, come Bodo Stern, già editor di Cell, che considera gli editori commerciali in parte corresponsabili della situazione attuale:
the fundamental bias built into for-profit publishing: Journals don’t get paid for rejecting papers. “We pay them for accepting papers,”
Secondo Yves Gingras, sociologo presso l’università del Quebec la situazione attuale è figlia della affermazione nelle nostre istituzioni del New Public Management
When universities and public institutions adopted corporate management, scientific papers became “accounting units” used to evaluate and reward scientific productivity rather than “knowledge units” advancing our insight into the world around us.
This transformation led many researchers to compete on numbers instead of content, which made publication metrics poor measures
Quanto raccontato nell’articolo di The Conversation è ormai noto da tempo, così come è evidente che un sistema della comunicazione scientifica (malfunzionante) basato sul publish or perish non può essere emendato.
Alcuni spiragli appaiono però nella chiusa dell’articolo. Bodo Stern, racconta che nella sua istituzione (Howard Hughes Medical Institute) viene richiesto a chi applica per un contratto di sette anni
[…] to write a short paragraph describing the importance of their major results. Since the end of 2023, they also have been asked to remove journal names from their applications.
Il National Health and Medical Research Council in Australia, da qualche anno ha avviato la politica top 10 in 10, con lo scopo di valutare la qualità piuttosto che la quantità di un numero limitato e definito di pubblicazioni.
Sempre Stern raccomanda la apertura dei report di revisione
journals should make all peer-review reports publicly available, even for manuscripts they turn down. “When they do quality control, they can’t just reject the paper and then let it be published somewhere else”.
Nel corso degli ultimi 10 anni la situazione sembra essersi aggravata in maniera davvero preoccupante, riconoscerlo (e come si potrebbe non farlo visto le evidenze?) non è più sufficiente ed è ormai arrivato il momento che ciascuno faccia la sua parte.

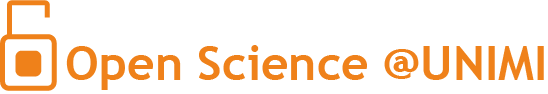
[…] open access è stato anche fatto capire che si sarebbe dovuto pubblicare più o meno tutto (vedi la commodification della editoria scientifica). La reazione dell’editor in chief è stata a questo punto di […]