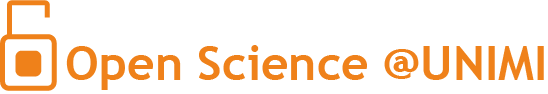Ulrich Dirnagl offre in questo illuminante contributo una visione consapevole (poco frequente) di cosa sta succedendo nell’ambito della editoria scientifica.
Cercheremo di riassumere qui i punti principali del testo che è in tedesco.
Già dal titolo si capisce dove l’autore voglia arrivare: Nessun DEAL con i nostri articoli! [DEAL significa accordo ma è anche la sigla del consorzio tedesco per l’acquisto di risorse elettroniche]: l’accordo sull’open access con il gigante editoriale Elsevier non solo non porta vantaggi, ma consolida il pessimo status quo dell’editoria accademica.
La prima parte dell’articolo illustra il ciclo di generazione della ricerca, di rendicontazione attraverso articoli scientifici e di validazione, un processo che avviene tutto entro la comunità scientifica e in cui gli editori intervengono ben poco. Ciononostante e per un meccanismo incomprensibile [o forse no] l’editore accademico è diventato il gatekeeper che decide delle carriere dei ricercatori
Trotzdem sind die Verlage die „Gatekeeper“ des wissenschaftlichen Publizierens, und das kommt uns im wahrsten Sinne des Wortes teuer zu stehen. Wissenschaftsverlage beschäftigen uns Forscher als Autoren, Gutachter und Herausgeber.
Se un tempo gli editori erano necessari per la disseminazione dei contenuti scientifici, oggi ciò avviene attraverso internet. Ma mentre la digitalizzazione ha portato in qualsiasi altro ambito a modifiche sostanziali dei processi l’editoria accedemica sembra non essersi evoluta né affrancata dai gatekeeper tradizionali.
Das akademische Publizieren dagegen ist in den Fünfzigerjahren des vorigen Jahrhunderts steckengeblieben. Und dies, obwohl das Substrat der Artikel, unsere Ergebnisse, mittlerweile praktisch zu hundert Prozent digital generiert und kommuniziert wird.
L’autore riconosce alla comunità accademica una certa pigrizia o superficialità o distrazione nel comprendere a quale prezzo chi lavora in ricche istituzioni pubbliche può facilmente accedere a molti contenuti scientifici, senza rendersi conto che la maggior parte delle persone (e anche dei ricercatori) da questo accesso restano escluse.
Dopo la Dichiarazione di Berlino gli editori hanno cominciato a preoccuparsi per i propri profitti, ma sono subito riusciti a trovare un nuovo modello, quello basato sulle APC. Le comunità si sono dichiarate entusiaste, non rendendosi conto che anche con questo modello si andava a pagare due volte (o più) la ricerca finanziata con fondi pubblici.
Das Geschäftsmodell der APCs beruht genau wie das der Subskriptionen darauf, dass die Gesellschaft die Verlage zum zweiten Mal für Produkte und Services bezahlt, für die sie die Wissenschaft bereits alimentiert hat – nämlich Forschen, Resultate zusammenschreiben, in Manuskriptform bringen und deren Qualität kontrollieren. Im Strudel der Begeisterung, dass dadurch viele Titel öffentlich zugänglich werden, hat man das wohl übersehen.
Ricercatori ed editori insieme hanno creato un sistema gerarchico delle sedi editoriali: La reputazione delle riviste, spesso misurata con l’Impact Factor, funge da valuta nell’economia della reputazione del mercato scientifico. E questa valuta viene scambiata dai ricercatori per ottenere finanziamenti, borse di studio, cattedre…
Le comunità scientifiche sono resilienti e pur rendendosi conto che il sistema del publish or perish non è un buon sistema, si adattano.
Viele schimpfen zwar über „Publish or Perish“, aber ändern sollen das allenfalls die Anderen: die Institutionen, die Fördergeber und so weiter. Denn letztlich wurden diejenigen, die das System gestalten und es somit auch ändern könnten, also die arrivierten Wissenschaftler, in ihm sozialisiert und selektiert. Und wenn Du einen Sumpf austrocknen willst, dann solltest Du nicht die Frösche fragen!
La cosa veramente irritante nel nuovo modello sembra essere il fatto che sia l’autore a dover pagare, e per questo i consorzi (già esistenti o meno) si specializzano nel contrattare i cosiddetti contratti trasformativi il cui scopo è togliere agli autori l’impiccio del pagamento e garantire agli editori di guadagnare almeno tanto quanto nel modello a sottoscrizione (ma spesso di più).
L’autore però sottolinea molto negativamente anche un altro elemento che da alcune parti invece viene citato trionfalmente come risultato positivo: la presenza di questi accordi spinge gli autori a preferire quelle sedi editoriali per cui non devono pagare e possono pubblicare ad accesso aperto creando disparità verso altre sedi editoriali.
Davon betroffen sind ausgerechnet Verlage wie EMBO Press, PLoS und eLife Sciences Publications. Das ist tragisch, denn diese agieren nicht gewinnorientiert (non-profit), legen ihre Kosten offen und generieren wirklichen Mehrwert für das akademische Publikationswesen.
La reazione di editori che non appartengono al club degli oligopolisti è stata quella di sviluppare strumenti nuovi per esempio per la peer review (open o post peer review) o di pubblicazione (preprint, preregistration). Tutte ottime iniziative di cui i colossi si sono poi appropriati facilmente non appena verificato che funzionano.
L’autore racconta poi delle trattative del consorzio tedesco con Elsevier che avevano portato ad una sospensione di qualsiasi accordo a partire dal 2016/17. L’interruzione del contratto ha permesso alle istituzioni un enorme risparmio, senza che la ricerca ne abbia minimamente sofferto. Gli autori hanno continuato a fare ricerca, a pubblicare su riviste Elsevier (senza pagare) e a leggere gli articoli di Elsevier. Finché nel 2023 il consorzio tedesco ha annunciato trionfalmente la chiusura di un nuovo contratto quinquennale.
Womit DEAL ein weiteres Mal ein aus der Zeit gefallenes akademisches Publikationswesen stabilisiert und perpetuiert – und damit gleichsam die alte Reputationsökonomie der Wissenschaft und die Verschwendung gesellschaftlicher Ressourcen.
In chiusura del suo articolo l’autore esorta a prendere in considerazione forme alternative a quella degli accordi ora in voga. Cita il documento del Consiglio dell’Unione Europea che invita gli Stati Membri ad investire in infrastrutture pubbliche e gestite dalle comunità disciplinari [l’Olanda sta proprio facendo questo mettendo a disposizione dei ricercatori 12,5 milioni di Euro] e ricorda che ci sono paesi (come il Sud America) dove il 70% degli articoli scientifici sono diamond. Un altro modo sembra essere possibile.