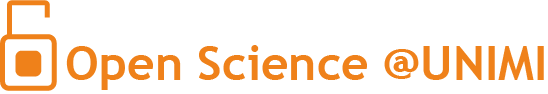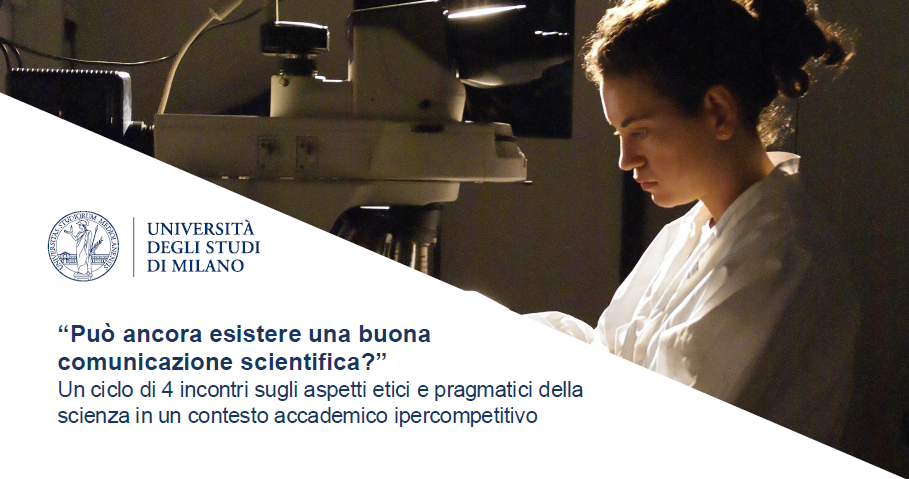
La Commissione Open Science e la Direzione Performance organizzano una serie di incontri sui temi della pratiche etiche della ricerca scientifica, l’influenza del contesto iper-competitivo, e i vantaggi della trasparenza e dell’adozione di protocolli di ricerca rigorosi ed aperti.
“Può ancora esistere una buona comunicazione scientifica?”
incontri sugli aspetti etici e pragmatici della scienza in un contesto accademico ipercompetitivo
Mai come in questo periodo la ricerca scientifica è stata sotto attacco.
Certamente sotto attacco da parte dei media, che riportando casi di comportamenti frodatori (dal plagio alla fabbricazione di dati falsi, dai paper mills alle riviste predatorie, dai review mills alle autocitazioni e ai cartelli di citazioni) hanno contribuito a plasmare un senso di sfiducia generalizzata rispetto ad un sistema della ricerca che gode (magari non in Italia ma certamente all’estero) di importanti finanziamenti pubblici.
La discussione sulla presenza di incentivi perversi che inducono i ricercatori a massimizzare la quantità di articoli pubblicati invece che la qualità, il rigore e il perseguimento di ricerche innovative con orizzonti di risultati di medio-lungo periodo, è esplosa anche all’interno della comunità scientifica, con i ricercatori stessi che testimoniano del clima tossico che caratterizza la comunità scientifica: pressati dalla necessità di pubblicare, alcuni sono caduti nella tentazione di ritoccare dati, o ignorare risultati negativi che contraddicevano le ipotesi di partenza, perché difficilmente pubblicabili.
A questo contesto, si aggiunge l’innovazione tecnologica: molti ricercatori hanno iniziato a far uso delle nuove applicazioni dell’intelligenza artificiale, come i LLM, per la stesura di testi o alcune analisi, spesso senza comprenderne appieno il loro funzionamento o le possibili implicazioni in termini di riproduzione di bias impliciti nei dati, perdita di controllo sulle analisi e omologazione del contenuto dei testi scientifici.
Alcuni editori commerciali, non solo quelli definiti “predatori”, interessati a massimizzare il numero di articoli pubblicati dalle riviste presenti nel loro portafoglio per remunerare – spesso copiosamente – i propri azionisti, nonché sistemi di valutazione della ricerca che premiano la quantità, completano un quadro che sembra cospirare contro la capacità della comunità scientifica di difendere pratiche di ricerca ispirate a rigore, metodo, disinteresse e innovazione.
Come possono rispondere le comunità scientifiche e le istituzioni pubbliche a una situazione in cui la letteratura scientifica sembra poter essere facilmente inquinata da ricerche inattendibili? Dove collocare il confine fra “buona” e “cattiva” ricerca?
Possono i principi fondamentali della scienza aperta – trasparenza dei processi, accessibilità di dati, metodi e testi, riproducibilità degli esperimenti e dei risultati delle ricerche – contribuire a difendere la credibilità della ricerca scientifica?
Pratiche rigorose e tracciabili, documentabili e verificabili sono fondamentali per il processo di ricerca, ma importantissima è anche la acquisizione di consapevolezza su cosa sia la frode scientifica, quali siano i confini tra rigore metodologico e pratica illecita e le conseguenze di quest’ultima. È importante promuovere la formazione soprattutto dei giovani ricercatori che si trovano in posizioni precarie sul mercato del lavoro accademico, sottoposti quindi a forti pressioni competitive, ma che possono anche essere importanti vettori di cambiamento.
Primi incontri programmati
Gli incontri saranno in modalità mista, in presenza e su MS TEAMS, il link al WEBINAR verrà indicato a ridosso degli incontri.
13 Settembre 2024 ore 15.00 Sala di rappresentanza via Festa del Perdono, Milano
Aprire la scatola nera della scienza: gli effetti della competizione tra scienziati sulla credibilità della comunicazione scientifica
Saluto del Rettore dell’Università di Milano Elio Franzini
Coordina: Flaminio Squazzoni (Commissione Open Science Università degli Studi di Milano)
Paolo Crosetto (Direttore di ricerca all’INRAE, Grenoble), economista comportamentale che ha studiato l’impatto del contesto istituzionale sul comportamento degli scienziati. L’editoria scientifica sotto pressione: crescita esponenziale, business model e punti critici
Hykel Hosni (Professore di logica presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università degli Studi di Milano), Errore e incertezza: due chiavi di accesso alla cultura scientifica
27 Settembre 2024 ore 14.00 Aula C03 via Mangiagalli 25, Milano
Intelligenza artificiale e ricerca scientifica: minacce ed opportunità in un contesto di scienza aperta
Coordina Silvana Castano (Professoressa di Informatica presso il Dipartimento di Informatica del nostro Ateneo)
Daniela Tafani (Ricercatrice di filosofia politica Università di Pisa)
Generatori di testi probabili e crisi della ricerca
Maria Chiara Pievatolo (Professoressa di filosofia politica Università di Pisa; presidente e componente del Direttivo AISA)
Open science e SALAMI: più bianco non si può?
Alfio Ferrara (Professore di Informatica presso il Dipartimento di Informatica del nostro Ateneo)
Quando mio partner intellettuale è una macchina …
Paolo Boldi (Professore di Informatica presso il Dipartimento di Informatica del nostro Ateneo)
Intelligenza artificiale: il capolinea della revisione tra pari?
N.I.N.A watch (gruppo nato a Milano a gennaio 2024 con lo scopo di indagare quale sarà l’impatto dell’intelligenza artificiale su alcune aree tematiche: lavoro, ambiente, ricerca)
Locandina
Slide degli interventi
Daniela Tafani: Generatori di testi probabili e crisi della ricerca
Maria Chiara Pievatolo: Open science e SALAMI: più bianco non si può?
Alfio Ferrara: Quando mio partner intellettuale è una macchina …
Paolo Boldi: Intelligenza artificiale: il capolinea della revisione tra pari?
N.I.N.A. watch
Video
21 Ottobre 2024 ore 9.00 Aula Magna via Festa del Perdono 3, Milano
Le regole del gioco nella ricerca in medicina
Coordina Aldo Giannì (Presidente del Comitato di Direzione Facoltà di Medicina e Chirurgia)
Commissione Open science Presentazione del toolkit Open Access: istruzioni per l’uso per la Facoltà di Medicina e Chirurgia
Luca De Fiore (direttore del Pensiero Scientifico Editore)
Sul pubblicare in medicina
Discutono con l’autore:
Emilio Clementi (editor della rivista Pharmacological research)
Giovanni Lodi (editor delle rivista Oral Diseases)
Marco Pedrazzi (LERU WG Research integrity e Presidente del Comitato etico dell’Università degli Studi di Milano fino al 2021)
Locandina
Slide degli interventi
Luca De Fiore: Science publishing: what’s next
Commissione Open Science: presentazione del Toolkit Open Access
Toolkit Open Access: istruzioni per l’uso Facoltà di Medicina e Chirurgia
Video
22 Novembre 2024 ore 10.00 Sala lauree Scienze Politiche, via Conservatorio 7, Milano
Ricerca, pubblicazioni carriere e risorse: verso una valutazione responsabile
Coordina
Flaminio Squazzoni (Coordinatore delle Commissione Open Science)
Alberto Baccini (Professore di Economia Politica presso l’Università degli studi di Siena)
Le regole della valutazione amministrativa e la cattiva scienza
Marco Seeber (Professore di Management pubblico – University of Agder)
Valutazione e accademia: da Baroni a burocrati?
EVENTI PASSATI
Webinar italiano sulla Barcelona Declaration
4 Luglio 2024, h 14.00-15.30
Le prime istituzioni firmatarie in Italia ti invitano a un evento online dedicato alla comunità italiana. Scopri le ragioni e le modalità per aderire alla Barcelona Declaration e partecipa attivamente alla presentazione di azioni concrete per l’implementazione dei principi che essa promuove.
- Esplora i motivi fondamentali per cui la Barcelona Declaration rappresenta un passo avanti necessario per la gestione delle informazioni sulla ricerca in Italia.
- Scopri le strategie e le azioni che puoi implementare nella tua istituzione per sostenere e promuovere i principi della Declaration.
Un ampio spazio sarà dedicato alle domande, ai dubbi e alle riflessioni dei partecipanti, creando un ambiente collaborativo e interattivo.
Non perdere questa opportunità di essere parte di un movimento che sta crescendo in tutta Europa e oltre per fare dell’apertura delle informazioni sulla ricerca la nuova norma.